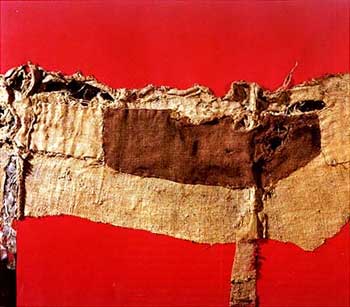| Le opere di Alberto Burri (1915-1995) sono astratte, informali,
materiche, ma nonostante la relativa ricchezza di aggettivi
loro attribuibili, le opere di Burri appaioni troppo limitate
da queste definizioni: meglio è dire semplicemente che
questo artista pone tra le sue priorità la materia, che
elabora con una sensibilità fisica ed un amore sensuale
e sofferto che trovano parallelo forse solo in Antoni Tàpies e nelle sue "tracce" materiche, eredità e testimonianza
della vita degli uomini.
Burri, che compie le sue sperimentazioni fondamentali tra
gli anni '50 e '60, in realtà non si preoccupa di tramandare,
usa materiali consunti, stracci, lamiere, legni combusti,
sacchi, materiali volgari, già vecchi, che danno da
subito la sensazione di una durata limitata nel tempo, destinati
a mutare, degradare, morire, in una chiara metafora di quello
che è il destino dell'uomo. E quando invece utilizza
materiali nuovi, li trasforma, li brucia, li tormenta, li
straccia, caricandoli, attraverso la sua azione, di un significato
inusuale ed intenso, sollecitandoci ad interrogarci sul loro
stato, su quello che erano prima dell'intevento dell'artista,
su quello che è accaduto perchè si siano trasformati
nell'immobile fissità di un'opera d'arte.
Ancora una volta, l'artista sublima i relitti, la materia
di scarto e di recupero, secondo il vecchio concetto dadaista
dell'objet trouvé, del ready-made di Duchamp, dei dipinti
polimaterici di certi futuristi, dei Merzbilder di Schwitters,
ma in Burri l'azione creativa coesiste con l'intenzione distruttiva
di accelerare con un intervento diretto il processo di consunzione
e di logoramento dei residui materici per inglobarvi il concetto
del tempo, che inesorabile trascorre e corrode: il fuoco,
l'essicazione (si veda la serie dei "Cretti" degli
anni '70) sono mezzi per attuare una forma di purificazione
che, devitalizzando l'oggetto, ne amplia il significato simbolico,
le "combustioni" sono materia danneggiata che perde
la sua integrità fisica per acquistare un significato
meta-fisico, perchè solo così può raccontare
la mutevolezza e la caducità della vita.
Come ogni essere umano, l'inerte materia ha un suo vissuto,
secondo una percezione quasi animistica e panteistica della
realtà fisica, partecipe delle vicende umane e come
l'uomo capace di sofferenze, di cambiamenti, di decadimento
e di morte: il concetto di un'arte costruita dall'uomo, destinata
ai posteri, a valenza universale, consegnata all'eternità,
viene così definitivamente superato in una visione
in cui "Non è l’arte che rappresenta la realtà:
è la realtà che si presenta da sé facendosi
arte" (Francesco Morante), conservando tutte le sue limitazioni
ed imperfezioni.
Al di là dell'eterogeneità dei materiali e
dell'apparente casualità degli accostamenti, le opere
di Burri sono sempre saldamente intelaiate in uno schema strutturale
fermo ed equilibrato, secondo una rigorosa legge compositiva
che regola rapporti di spazi, dimensioni e relazioni tra le
masse cromatiche, e, seppure in modo inusuale, determina timbri
ed accenti con gusto quasi classico, sfruttando le diversità
dei materiali eterocliti e le loro caratteristiche superficiali
e volumetriche.
Sono tutti elementi facilmente leggibili in questo "Sacco
e rosso" del 1955, 180x158 cm, una composizione di sacchi
su fondo rosso, una delle molte versioni realizzate, posizionata
trasversalmente al centro del supporto, secondo una sostanziale
simmetria, dove gli effetti pittorici e plastici sono affidati
alle diverse tonalità delle tele, mosse in diversi
spessori e sovrapposizioni, sfilacciate e strappate, percorse
da una "sofferenza" tutta umana che le ha, nel tempo,
sdrucite e consunte fino a farne umili testimonianze di una
"vita" passata con la stessa fatica e lo stesso
dolore che percorre la vita di tutti noi, poveri uomini su
questa terra.
Lo stesso Burri dice :"Nel sacco trovo quella perfetta
aderenza tra tono, materia e idea che nel colore sarebbe impossibile."
E' un sentire laico, mistico e romantico, di contenuta empatia,
la visione di un mondo precario e destinato alla fine nella
poetica di un artista di grande spessore umano e morale, che
ha contribuito in maniera determinante a ridefinire quel mutato
rapporto tra arte e vita alla base di tutta la
cultura moderna nel mondo occidentale.
link:
Celebrazioni per la nascita di Alberto Burri
|