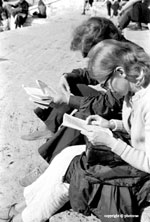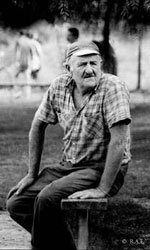| home
arte
architettura
arte moderna
art reader
fotografia
nuove tendenze
nonsoloarte
pillole
purezza formale
concorsi
eventi e mostre
artisti
collaborazioni
testi
links
contatti
|
| |
APPUNTI |
|
| Testi e commenti di Vilma Torselli su Antithesi, giornale di critica d'architettura. Il più letto in Artonweb: fotografia |
| |
FOCUS ON |
|
Libri
American Art 1961-2001 la storia dell'arte moderna negli Stati Uniti tra due momenti decisivi della storia americana, la guerra del Vietnam e l'attacco alle Torri Gemelle. |
Musei
Milano, apre il Museo delle Illusioni, con incredibili installazioni, illusioni visive, giochi e rompicapi. |
Concorsi
Concorso artistico Lucca Biennale Cartasia 2022, tema conduttore di questa edizione “The white page” (pagina bianca), le infinite possibilità per gli artisti di raccontarsi tramite le opere in carta.
|
Premi
I vincitori del Premio Pritzker per l'architettura 2021 sono Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal: talento, visione e impegno per migliorare la vita delle persone. |
In Italia
Al Palazzo Ducale di Genova, dal 9 settembre 2021 al 20 febbraio 2022 grande mostra di Maurits Cornelis Escher. |
All'estero
Parigi, all’Espace Lafayette-Drouot "The World of Bansky”, su 1200 mq. esposte un centinaio di opere del più famoso street artist del mondo. Fino al 31 dicembre 2021.
|
|
 | La
soggettività dell'obiettività
di Vilma Torselli
pubblicato
il 03/08/2006 |
| "Non
colui che ignora l'alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia, sarà
l'analfabeta del futuro". (Walter Benjamin che cita Laszlo Moholy-Nagy) |
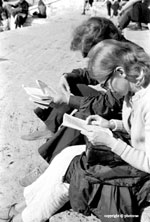

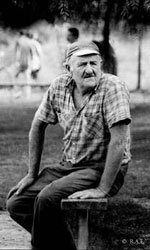
 |
La fotografia rappresenta oggi la forma di comunicazione più diffusa
e più efficace in una civiltà dell'immagine,
per usare una definizione abusata ma appropriata, che privilegia
la visione come forma di conoscenza.
Dando per superata, in modo definitivo, senza rimpianti
e con buona pace di Walter Benjamin, l'idea di un'aura dell'immagine
legata alla sua unicità, anacronistica e riduttiva
in una società della cultura di massa in cui tutto
è alla portata di tutti, la fotografia ha minato
il concetto dell'esclusività del pezzo unico fruibile
da una elite ristretta e privilegiata ed ha invece affermato
quello di un oggetto, artistico o semplicemente comunicativo,
che, riprodotto indefinitamente in un numero illimitato
di esemplari, dà vita a pezzi tutti 'autentici' ed
in un certo senso 'unici'.
Per la verità va detto che
Benjamin non lega alcun giudizio esplicitamente negativo ad un processo che, prima
che culturale, è di natura storica e sociale e non modifica sostanzialmente
il concetto di arte visiva intesa come scambio di comunicazioni mediante un linguaggio
segnico.
Nel caso della fotografia ciò è accompagnato da un valore aggiunto rappresentato
dal fatto che l'illimitatezza quantitativa si lega ad un livello qualitativo immutato
dalla prima all'ultima copia, il che non avviene, per esempio, per la riproduzione
litografica o serigrafia, che comporta un progressivo scadimento del risultato.
Questa
rivoluzione copernicana indotta dalla riproducibilità tecnica dell'immagine
si è legata ad una crisi del concetto di soggettività causata da
una supposta capacità della fotografia di riprodurre la realtà oggettiva
in quanto medium meccanico e come tale delegato al compito di copiare fedelmente
un modello nel modo più neutro possibile: non a caso, il termine 'obiettivo' (o l'equivalente 'obbiettivo')
è aggettivo qualificativo con significato di " imparziale, oggettivo, basato
sui fatti ' - definizione tratta da 'De Mauro, dizionario della lingua italiana " - ed al tempo stesso sostantivo che identifica quella parte della macchina fotografica,
l'obiettivo, appunto, attraverso la quale il fotografo guarda e restituisce in
immagine ciò che osserva. |
Tuttavia,
a partire da Cartier-Bresson e da tutta una generazione
di fotografi suoi contemporanei con i quali si sono consolidati
due fondamentali filoni espressivi, la documentazione -
di eventi o personaggi - e la rappresentazione, per immagini,
di situazioni e stati d'animo, il dibattito tra oggettività
e soggettività nella fotografia pare risolto e oggi
non sussistono dubbi sul fatto che l'autore inevitabilmente
eserciti personali e soggettive opzioni sulla scelta del
frammento di realtà che decide di fotografare, sulle
condizioni di luce, sul punto di vista e su una lunga serie
di situazioni variabili nelle quali trascrivere la propria
visione del mondo, lo stato d'animo, le intenzioni, la cultura,
il vissuto, insomma uno stile personale, soggettivizzando
inequivocabilmente il risultato finale.
"Secondo Barthes, quando si dice che la fotografia è
un linguaggio si dice qualcosa di vero e falso al tempo stesso: falso in senso
letterale, poiché l'immagine fotografica è analogica rispetto a
ciò che rappresenta, e dunque non comporta nessuna unità elementare
discontinua che si possa chiamare segno; vero, nella misura in cui nella fotografia
sono soprattutto la composizione e lo stile a funzionare come un linguaggio. Lo
stile ci dice così di una specificità del segno fotografico che
non appartiene alla dimensione della denotazione, bensì a quella della
connotazione. In questo senso, lo stile come linguaggio proprio della fotografia
mette innanzi tutto in gioco la problematica della soggettività".(Patrizia
Calefato / scienze e tecnologie della moda /fotografia - Camera lucida: note sulla
fotografia).
Al pari di ogni altra forma di scrittura, la fotografia è
quindi un linguaggio con spiccate diversità grafologiche legate alla presenza
di un autore, del suo intelletto e della sua personale emotività che invoca
il diritto alla soggettività, mezzo per articolare un discorso per immagini
fatto di rimandi, metafore, allusioni nel quale, come asserisce Wim Wenders, "c'è
la presenza di chi viene fotografato e di chi sceglie l'inquadratura e scatta". |
| ************************* |
Il commento di seguito riportato, a firma di Miro Dragan, correda il mio scritto di una serie di informazioni e precisazioni (reperibili anche in Wikiquote) senz'altro utili ad una più completa documentazione per il lettore, anche se ininfluenti alla comprensione del mio testo. Che parte dalle considerazioni sulla riproducibilità dell'immagine formulate da Benjamin, il quale avrà avuto i suoi buoni motivi per 'appropriarsi' di una frase altrui manifestatamente dichiarando di condividerla facendola propria, tanto che la scrive "senza riportare il nome di Moholy-Nagy".
Alla luce di ciò, mi permetto di contestare il fatto che la citazione si possa definire 'errata', in quanto riportata effettivamente da Benjamin, seppure in seconda battuta.
E' Benjamin che fà sue le parole di Laszlo Moholy-Nagy, ed io riferisco parole di Benjamin che a sua volta riferisce parole di Moholy-Nagy. La funzione introduttiva della frase, che risulta in un certo senso doppiamente autorevole, non cambia chiunque l'abbia pronunciata, nè cambia la sua pertinenza all'argomento.
Tant'è che lo stesso Benjamin, come rileva Dragan, non giudica necessario citarne Moholy-Nagy quale autore, evidentemente ritenendo che essa valga per entrambi come espressione di un concetto condiviso e che non ci sia copyright sulle parole con il quale viene espresso. |
Scrive Miro Dragan:
"L'aforisma attribuito a Walter Benjamin a margine dell'articolo "La soggettività nell'obiettività" a cura di Vilma Torselli è erroneo."
Nel 1931 Walter Benjamin pubblica nella rivista berlinese Die literarische Welt un saggio dal titolo Piccola storia della fotografia che si conclude riportando e commentando una frase del pittore e fotografo ungherese, attivo a Berlino, Laszlo Moholy-Nagy: “Non colui che ignora l’alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia, sarà l’analfabeta del futuro”
L’artista proclama l’avvento della società della visione e dei suoi nuovi linguaggi; Benjamin commenta causticamente: “Ma un fotografo che non sa leggere le proprie immagini non è forse meno di un analfabeta?” riportando l’indice dell’attenzione sulla capacità di comprendere i contenuti.
Tutto questo è contenuto nell’edizione italiana (Einaudi ed. 1966/ 91/ 2000), W. Benjamim, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, dove Benjamin, senza riportare il nome di Moholy-Nagy, scrive:
“Non colui che ignora l’alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia -è stato detto- sarà l’analfabeta del futuro” ed aggiunge:”Ma un fotografo che non sa leggere le proprie immagini non è forse meno di un analfabeta? La didascalia non diventerà per caso uno degli elementi essenziali dell’immagine?”
Segue.....
Miro Dragan
Contatti: mirodragan@libero.it |
|
|